INTERVISTA A EDOARDA MASI [1]
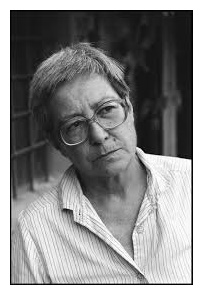
Per gentile concessione della rivista di poesia e filosofia Kamen’ [2]
E.M. – Nel XIX secolo è risultata chiara, ed è stata analizzata nella teoria economica e sociologica, la contrapposizione fra capitale e lavoro e la complementarietà dei due poli. Essendo il lavoro l’elemento vitale del capitale, la lotta contro il capitale cresceva dall’interno dei meccanismi di quest’ultimo. Il lavoro si incarnava nel proletariato industriale – non solo avversario del capitale perché oppresso, sfruttato ecc., ma perché sua componente necessaria e contraddittoria. La possibilità di uscire da quel sistema si fondava sul lavoro, che ne era a un tempo la componente base e il nemico radicale.
K. – Il paradigma del lavoro era proprio quello.
E.M. - Sì, non si trattava solo di ideologia: della validità di quella teoria abbiamo una prova storica in centocinquanta anni di lotta.
K. - Era un corrimano, uno strumento razionale che permetteva di mettere in evidenza una prospettiva, un certo numero di fatti. Le due classi sono un portato storico della rivoluzione industriale: non c’è l’una senza l’altra, in un legame fondamentale.
E.M. – Nella sua trionfale evoluzione il capitale ha finito, nella fase presente, con il divorare letteralmente sia la classe proletaria sia quella borghese. Nel Manifesto del Partito comunista c’è un’espressione sottolineata da Hobsbawn, a cui di solito non si bada: Marx dice grosso modo che, a un certo momento, il capitale dovrà essere superato dal lavoro oppure si avrà la fine di entrambe le classi in lotta. Credo che proprio questo si sia verificato. Una cosa è la borghesia, una cosa è il capitale. Questo è un meccanismo economico, mentre la borghesia è la classe dirigente che lo ha gestito in una ascesa sociale durata secoli fino al trionfo nell’Ottocento. Oggi gli eredi della borghesia non hanno più il carattere di classe dirigente. Il tratto di una classe dirigente è quello di difendere sì i propri interessi economici, ma nello stesso tempo di riuscire a rappresentare in qualche modo anche interessi generali.
K. – Per un’etica di classe?
E.M. - Prima che per un’etica, per necessità di fatto. Ad esempio, prendiamo la miserabile piccola borghesia italiana. Al momento dell’unità, per poter gestire lo sviluppo ha dovuto promuovere l’istruzione universale, costruire le infrastrutture, creare i servizi pubblici, ecc. Questo era nell’interesse anche pubblico. Non le era dato perseguire i propri interessi di classe senza costruire un’entità superiore, lo stato-nazione; che finiva col rappresentare tutti i cittadini, pur nelle differenze sociali.
K. – L’idea che ha interpretato ad esempio, in epoca più recente, anche Olivetti.
E.M. - Sì, Olivetti in modo ancora più accentuato perché era anche un innovatore. Esisteva una dimensione della politica che non era la stessa identica dimensione della struttura economica.
K. – C’era un senso del privato e del pubblico, di una loro suddivisione che oggi non c’è più. Non è il frutto di un certo Sessantotto?
E.M. - Secondo me, no; è il frutto di una evoluzione del capitale. Oggi il capitale dominante è in primo luogo quello finanziario, che è cresciuto enormemente; e poi il capitale speculativo. La recente crisi asiatica, ad esempio, è dovuta al capitale speculativo: un capitale che pretenderebbe, in certo qual modo, di eliminare il lavoro e vivere su se stesso, come fosse il gioco della roulette. È un assurdo, poiché lo stesso capitale finanziario, che genera la speculazione, si basa sul lavoro, sulla produzione. Se non ci sono merci non si ha profitto: se non si ha profitto, non si ha speculazione. La tendenza del capitale, tendenza suicida, è quella di eliminare oggi il lavoro che lo minaccia.
K. - In che senso lo minaccia?
E.M. – Perché il lavoro pretende sempre più di essere interamente remunerato, a scapito del profitto e quindi della possibilità stessa dell’accumulazione e della riproduzione allargata – la cosiddetta “crescita”, senza la quale la struttura del capitale crollerebbe.
Uno dei mezzi con cui il capitale oggi (ma la tendenza era già visibile nell’Ottocento) tende in modo ancor più clamoroso a liberarsi del lavoro, con le sue giuste rivendicazioni, è la colonizzazione. Già Rosa Luxembourg aveva elaborato una teoria secondo me valida nella sostanza, nonostante le critiche ricevute per le carenze nei calcoli tecnico-matematici: il capitale ha avuto bisogno di espandersi fuori delle sfere industrializzate, perché vi trova manodopera disponibile, senza limiti, a costi bassissimi. Oggi la tendenza si è estesa al punto di coinvolgere non solo la manodopera industriale malpagata, ma il mondo contadino, dove le transnazionali sono penetrate direttamente attraverso il sistema dell’agribusiness, dei brevetti dei semi, ecc. Vi è quindi un controllo diretto dell’agricoltura nei paesi dove i lavoratori per la maggioranza coltivano la terra o abitano nelle zone rurali. Il controllo e la rapina colpiscono pure gli agricoltori benestanti, soggetti alle transnazionali che, in luoghi ricchi dal punto di vista naturale, si appropriano delle sementi e le brevettano diventandone i proprietari. Perfino i floricoltori di San Remo, ad esempio, sono obbligati ogni anno a ricomprare i semi dei loro fiori, che non appartengono più al regno della natura: hanno subito modifiche biologiche per cui spesso non si riproducono più nel secondo anno. E anche quando tecnicamente non è così, lo è comunque sul piano giuridico, perché i semi brevettati non sono proprietà di chi li usa. Negli Stati Uniti questo è accaduto da tempo anche per il pollame, le uova, ecc. Sono convinta che una delle campagne importanti da fare sia quella contro la cosiddetta “proprietà intellettuale” – che in questo come in ogni altro campo ha ben poco a che vedere con la difesa dei “prodotti dell’intelletto”, ma è uno strumento di dominio economico delle grandi corporazioni.
Nella struttura in apparenza sfuggente assunta oggi dal mondo capitalistico, sembra che non riusciamo a trovare l’equivalente di quello che era stato un tempo il lavoro, la forza che possa combattere strutturalmente questo sistema. Si fanno manifestazioni contro la guerra: il fronte dei partecipanti è molto ampio e vi sono tante motivazioni eterogenee. Nel complesso, però, sono motivazioni etiche e interne al sistema stesso, prive di un progetto alternativo.
K – è già molto questo però!
E.M – No. è molto nel senso che si è formata una massa di gente che protesta. Ma poi si trova impotente, perché non è in grado proporre niente che sia alternativo a questo sistema.
K. – Ma l’etica è per noi strutturale, come l’arte, il pensiero ecc... Che ne pensa?
E.M. – Le motivazioni etiche, come quelle utilitarie, sono il punto di partenza delle posizioni assunte dagli individui e delle loro azioni. Dopo di che è necessaria un’analisi della realtà – risalire ai motivi e alle cause che generano i fatti che ripugnano alla nostra visione morale – e l’elaborazione di progetti alternativi e di strategie politiche. Diversamente, saremo solo quel che Hegel chiamava “anime belle”.
K. – Ma riprendiamo il discorso sulla incapacità di ripensare un progetto alternativo: in tutto questo non si rimette in gioco la funzione degli intellettuali e della politica e la crisi della ragione illuminista, in termini francofortesi, l’avanzare della ragione strumentale, in un sistema della ragione che diventa autoreferenziale in una corsa dei saperi e delle discipline all’autoreferenzialità?
E.M. – Questo perché la dialettica dell’illuminismo ha percorso la sua parabola. Se poi ci riferiamo al lavoro specifico degli intellettuali, bisogna riconoscere che non tutti, ma una loro minoranza fra cui non pochi americani, a cominciare da Chomsky, l’analisi di come funziona questo orrendo sistema ce la fanno. Disponiamo di tutti i dati, intere biblioteche, per vedere come tutto ciò funziona. Quello che non viene fatto è il passaggio ulteriore alla politica. Constatiamo, per esempio, che dietro alla guerra in corso vi sono da un lato gli interessi petroliferi, dall’altro il disegno di egemonia mondiale degli Stati Uniti (che devono impossessarsi dell’Asia occidentale e centrale per poi procedere verso oriente, mettendo in difficoltà anche l’Europa). Questo è abbastanza chiaro. Quel che non viene spiegato è il rapporto tra questa prassi e i fatti strutturali che la determinamo. Perché gli americani, che in fondo hanno una grande tradizione democratica e proprio nel settore più conservatore sono stati a lungo isolazionisti, sono passati a una politica di espansione globale? Che cosa c’è dietro? Perché questa trasformazione? è su questo che secondo me oggi non si fa più l’analisi. Un tempo si sarebbe detto, si fa l’analisi della sovrastruttura e non della base economica strutturale.
K.– Ma un’economia che si basa prevalentemente sul capitale finanziario può stare in piedi? E non è un effetto di quell’ansia e autonomia schizofrenica dei saperi che non fanno più struttura?
E.M. – Questa è una situazione di suicidio, che però trascina nella morte il mondo intero, anche sul piano ecologico, assolutamente distruttiva. Uno dei grandi pensatori di oggi, István Mészáros, ungherese allievo di Lukács, che lasciò l’Ungheria nel 1956 e da molti anni è professore di filosofia in Inghilterra, ha pubblicato nel ‘95 l’ultimo grosso libro, intitolato Oltre il capitale. È stato tradotto in molte lingue, e ha avuto in America Latina più di una edizione in pochi mesi. Rovesciando con una battuta un’affermazione di Schumpeter, secondo il quale il capitale procede a una distruzione costruttiva, Mészáros dice che attualmente il capitale costruisce la distruzione. È effettivamente così. Si uscirà dallo stallo? Personalmente ho poca fiducia che se ne esca partendo dall’Europa, è più probabile che dall’Asia e da una parte dell’America Latina vengano dei cambiamenti.
K. – Un pensatore come Amartya Sen, l' economista, che dici di lui?
E.M. – è bravo, ma non è solo, tutta l’India è ricca di vita intellettuale, politica, scientifica. Anche il movimento delle donne indiane produce pensiero.
K. – Non è come noi che siamo a fare il nulla.
E.M. – No, non si può dire per gli individui, ma è nel complesso che l’Europa in questo momento... Vedi, anche la resistenza francese che è ammirevole rispetto alla schifezza di casa nostra, secondo me è residuale, si basa ancora sulle idee golliste dello stato-nazione. Allora, perché Francia sì e Italia no? Perché i francesi godono di un’enorme eredità che li rende ancora forti, uno stato-nazione che risale a Giovanna d’Arco e anche prima, a Luigi IX; e poi l’eredità della rivoluzione, e quella napoleonica. Lo stato napoleonico non è uno scherzo. Napoleone non è stato solo un guerriero, ha costruito un sistema giuridico, il codice civile, la grande struttura amministrativa... Tuttavia questa eredità è residuale.
K. –Ha detto un’amica e storica francese che questa attività residuale ha coalizzato tutto il paese, destra e sinistra.
E.M. – Meno male, ma non apre a un futuro. è un po’come la Toscana in Italia: è il paese dove si sta meglio, regge su un passato. Mentre per esempio Milano è uno sfacelo. Ma in un certo senso Milano è più avanti della Toscana, giacché per lo sfacelo si deve passare.
K. – Edoarda Masi è nota al pubblico colto
soprattutto come sinologa. Com’è la situazione attuale della Cina,
rispetto a quella di anni fa.
E.M. – Una giovane giornalista del Manifesto, molto brava, Angela Pascucci, che si occupa degli esteri ma soprattutto della Cina, è stata di recente a Shanghai e ha scritto un articolo sulla FIAT di Nanchino. Mi aveva mandato questo pezzo per un parere; lei non ne era soddisfatta, eppure era un articolo ottimo. Le ho detto che non deve preoccuparsi se non è soddisfatta di quello che ha scritto perché oggi scrivere sulla Cina è difficilissimo, a meno che non si ripieghi sulla critica letteraria; cosa relativamente agevole, perché hanno scrittori notevoli, sia narratori che poeti. Hanno dei poeti straordinari. I cinesi per tradizione hanno sempre avuto un grande poesia. é un paese che si esprime in poesia.
K. – Sono tradotti in italiano questi poeti?
E.M. – Sì, in parte. Tradurre la poesia cinese è straordinariamente difficile, specie in italiano. È leggermente più facile tradurla in inglese. La lingua cinese non è flessa ed è molto sintetica. La lingua europea più sintetica e meno flessa è l’inglese. Se hai un verso cinese di cinque sillabe, in italiano diventa di venticinque sillabe. È necessario un vero poeta per tentare un equivalente. Questo vale per qualsiasi poesia, ma per la poesia di una lingua così diversa l’ostacolo è maggiore. Allora, alcuni fra i più grandi traduttori non poeti scelgono di fare quelle che Fortini chiamava traduzioni di servizio. Come nelle versioni interlineari, ti dicono il senso parola per parola, ti dicono il suono di ogni carattere cinese, e poi dànno una semplice versione in prosa del testo. È il metodo seguito da David Hawkes per Tu Fu. (Per il suono adotta la pronuncia di oggi, diversa da quella dell’epoca Tang – Tu Fu è dell’ottavo secolo. Tuttavia, pur essendo cambiato il suono, le rime rimangono nel passaggio alla pronuncia odierna, come pure, naturalmente, i toni.) Hawkes aggiunge una breve esposizione sulle circostanze in cui il testo è stato scritto; segue l’esegesi sulla forma, sulla metrica, che in quell’epoca era rigidamente regolata. Con questo metodo sono riuscita a far leggere la poesia in cinese a gente che della lingua cinese non sapeva nulla. Anche François Cheng, sinologo francese, traduce con questo sistema. Invece il grande Arthur Waley traduceva in inglese direttamente e riusciva a farlo bene, favorito comunque dalla lingua inglese.
I poeti contemporanei sono particolarmente difficili da tradurre, sono poeti di avanguardia e per di più con molti riferimenti alla poesia tradizionale. Sono di difficile lettura anche per i cinesi. Nell’opera di traduzione è benemerita Claudia Pozzana, che è lei stessa autrice di versi e da anni segue la nuova poesia cinese. Ha il merito di pubblicare sempre le sue traduzioni col testo originale a fronte. Ha tradotto bene, per esempio, Yang Lian. Eppure devo dire che quando Yang Lian è venuto a Milano e ha fatto ha fatto una lettura dei suoi versi, è stata una cosa straordinaria, era bello sentire l’originale, la forza dell’originale. La traduzione ti aiuta, se non avessi avuto la traduzione, forse non avrei capito neanche il senso; però molto va perduto. Non è facile tradurre neanche i prosatori contemporanei, ma per i poeti è veramente difficile.
Dicevo che parlare della Cina attraverso la mediazione degli scrittori è più facile. È un paese immerso in tremende contraddizioni, eppure è estremamente vitale. C’è la critica, c’è il pensiero, c’è la scrittura, è un paese culturalmente in effervescenza. È impossibile prevedere se procederà verso una crescita o verso un’involuzione (indipendentemente dal successo economico e politico, incontestabile).
Un giudizio sulla situazione politica è quasi impossibile. Un giudizio politico, per quanto si voglia distaccato e obiettivo, comporta una presa di posizione dell’osservatore. Dobbiamo tenere in considerazione che oggi la Cina si presenta come possibile bersaglio futuro degli Stati Uniti nella loro pretesa di egemonia sul mondo. Di fronte a una situazione simile, non solo chi per motivi di studio e di frequentazione ha come me in quel paese una seconda patria, ma anche qualunque persona civile non può non schierarsi dalla parte della Cina, potenza pacifica che rischia di essere aggredita e strangolata. Il problema delle sfere dirigenti americane è su come sia meglio strangolarla. Discutono su questo: basterà la penetrazione capitalistica per controllarla? Oppure no, giacché con lo sviluppo del capitale crescerà come grande potenza indipendente, sfida e ostacolo alla nostra egemonia globale? meglio allora aggredirla anche militarmente. Il dilemma è di questo tipo, riguarda il come strangolarla. Su questo piano la Cina va comunque appoggiata, senza molte distinzioni fra popolo e governo.
D’altra parte chi studia la storia sociopolitica della Cina è portato a un atteggiamento fortemente critico di fronte all’attuale governo. Per esempio, hanno fatto di tutto per entrare nell’Organizzazione mondiale del commercio. Ma apertura al mercato con il WTO significa subalternità. Hanno puntato sull’investimento di capitali esteri e sulla produzione per l’esportazione: il che li mette in condizione d’essere ricattati e di possibile instabilità. La situazione economica interna è spaventosa perché spaventosa è la forbice che dal punto di vista del reddito e delle condizioni di vita divide i vari strati della popolazione. C’è una minoranza piccolissima straricca, e un buon numero di abitanti delle maggiori città che se la cava: un tenore di vita inferiore al nostro ma decente. Il sessanta per cento della popolazione vive nelle campagne e sta sempre peggio. La riprivatizzazione della terra coltivabile – per altro assai scarsa – ha prodotto l’espulsione dal lavoro di un gran numero di persone. Si è tornati a un fenomeno proprio dell’epoca prerivoluzionaria, la formazione di un “popolo vagante” di centinaia di milioni, migranti interni per miseria totale, che si accampano in baraccopoli ai margini delle città.
K. – è sottoproletariato urbano?
E.M. – Non è tanto un sottoproletariato, è un vero e proprio proletariato perché si tratta di lavoratori, sottopagati e supersfruttati. Sono l’equivalente degli immigrati da noi (prima dal sud al nord, ora dai paesi asiatici, africani, latinoamericani). Lo sono anche amministrativamente. Per esempio in zone ricche come Shanghai. La Cina è divisa in province intese alla latina, una provincia ha le dimensioni di uno stato europeo. Shanghai e Pechino, che sono le città più grandi, hanno una amministrazione propria, non fanno parte della provincia che hanno intorno, ma formano come una provincia a sé. L’amministrazione di Shanghai per accogliere quelli che vengono dalle altre province richiede ben tre permessi di soggiorno: uno di polizia, uno per l’alloggio, e un contratto di lavoro. Senza di questi, se uno viene beccato viene messo in un centro di detenzione temporanea. È interessante questa analogia con quanto accade da noi, a prova che non si tratta di un meccanismo razzista, ma del frutto di un sistema economico, tanto da presentarsi anche fra abitanti della stessa nazionalità.
Questi irregolari sono in parte tollerati perché sono lavoratori non protetti, a basso salario, che vengono adoperati principalmente nell’edilizia, dove si costruisce con velocità sbalorditiva, in pochi mesi si trasformano le città. Questi operai lavorano a cottimo di gruppo, se il gruppo entro il termine non consegna il lavoro, non viene pagato, semplicemente. Sono sistemi brutali di capitalismo selvaggio. A volte a profitto di capitale misto cinese e estero, a volte di solo capitale cinese. Il capitale estero è poi spesso di cinesi all’estero. Esiste una Cina della costa diversa dall’interno e dal nord, dove prevale il commercio. Già nel passato commercianti e anche banchieri cinesi si sono diffusi per l’ambiente del Pacifico. Gente che manovra denaro in Indonesia, nelle Filippine, e fino negli Stati Uniti...
K. – La Cina rimane ancora in gran parte un paese rurale?
E.M. – è rurale nel senso che la maggioranza della popolazione vive in campagna. Maria Regis diceva che l’avvenire della Cina può essere solo industriale e non rurale. Benché abbia una grande estensione, la terra coltivabile è scarsa. La maggior parte della terra è fatta di deserti e montagne. Rispetto all’enorme popolazione sempre in crescita, anche col migliore dei sistemi di coltivazione non sarebbe in grado di nutrire i suoi abitanti. Ha sempre importato cereali, anche nell’epoca di Mao importava cereali dall’Australia, dal Canada... Non è un paese che possa contare su un’agricoltura ricca, come certi paesi dell’America Latina, rovinati per altri motivi. Dopo la morte di Mao, nei primi anni del governo di Deng Xiaoping, c’è stato un relativo miglioramento delle condizioni di vita in una parte delle zone rurali, grazie a una politica di prezzi che favoriva i prodotti agricoli. Ma in generale i contadini stavano meglio semplicemente perché si erano messi a fare una quantità di mestieri, diciamo di piccolo commercio, sul quale i più abili o furbi o fortunati hanno lucrato, a danno di altri. La terra è stata ridistribuita ai coltivatori – misura inopportuna data la estrema scarsità di terra coltivabile. A ogni famiglia tocca una superficie coltivabile microscopica, che non consente ai suoi membri di mantenersi in vita. Anche prima delle riforme socialiste un certo grado di cooperazione era indispensabile. L’unico modo per poter sopravvivere è collaborare. Un gruppo di famiglie, una cooperativa, una comune potevano acquistare e impiegare utilmente macchine agricole e altri mezzi di produzione, proibitivi e anche eccessivi per la singola famiglia.
La collettivizzazione degli anni Cinquanta non ha avuto il carattere drammatico che aveva avuto in Russia. In Russia una parte dei contadini era contraria, non così in Cina, dove si è trattato di un fenomeno semispontaneo, partito dalla base. Il disaccordo ci fu in seguito, quando si tentò nelle comuni una sorta di “militarizzazione” della vita quotidiana, che ai contadini non piaceva. L’idea di mangiare alla mensa invece che a casa era senza dubbio più razionale, si risparmiavano soldi, tempo e fatica; ma a una famiglia contadina piace mangiare a casa sua secondo la tradizione. Certi eccessi non sono piaciuti ai contadini, ma l’idea di fare le cooperative era bene accetta.
La redistribuzione della terra ha finito col portare molti alla miseria, alla fuga. Il più furbastro riusciva ad accaparrarsi la terra migliore, poi prendeva gli altri come braccianti (ora è consentito) e cercava di produrre il più possibile, sfruttandoli e riducendone il numero al minimo. Così è cominciata l’enorme fuga, e in certi casi perfino l’abbandono della terra – un paradosso in un paese che non ha terra sufficiente per nutrire i suoi abitanti.
La burocrazia cinese è particolarmente brava, ha alle spalle più di duemila anni di esperienza. Finora è riuscita a stare in equilibrio in una situazione assurda, in cui per un verso si continua il controllo statale sull’economia e per l’altro si apre al mercato internazionale: due cose che fanno a pugni. Finora si sono barcamenati, naturalmente con una serie di contrasti: fra poteri locali e centrale, la connivenza fra privati e funzionari statali, con corruzione a livelli incredibili.
K. – E Tien an men?
E.M. – Tien an men è stato uno dei risultati di questa politica. Come è stata diffusa nel mondo dalla CNN, la faccenda è apparsa centrata unicamente sulla rivolta studentesca, si è omesso il fatto che mentre gli studenti protestavano a piazza Tien an men, quattro milioni di cittadini di Pechino erano in rivolta, e poi milioni e milioni di cittadini delle grandi città della Cina. C’è stata la rivolta guidata dai sindacati liberi. I primi militari inviati a domare la folla sono stati pacificamente persuasi da questa a desistere: le donne di Pechino mettevano i loro bambini in braccio ai soldati. Allora per “riportare l’ordine” hanno dovuto mandare soldati da province lontane che parlano altri dialetti e che non potevano comunicare con la popolazione. Era stato loro raccontato che a Pechino c’era una rivolta contro il socialismo e bisognava domare i controrivoluzionari. Quei poveracci hanno condotto l’operazione senza sapere quel che facevano, non potendo comunicare. Non si trattava solo degli studenti nella piazza, era in rivolta gran parte della Cina urbana. I motivi dell’insurrezione sono tanti, è l’insieme dei motivi per cui la popolazione nelle sue varie componenti era contro la politica governativa. Per spiegarli occorrerebbe una lezione di più ore sulla storia della Cina. Fra gli studenti le motivazioni erano abbastanza confuse, una rivendicazione da un lato per la democrazia, dall’altro per il benessere del popolo. Un amico cinese mi diceva che quelli di Tien an men erano principalmente figli di quadri, si trattava cioè di una faccenda quasi interna al partito. Però hanno innescato una rivolta generale del popolo. Questo non è nuovo in Cina. Gli studenti sono stati quelli che hanno innescato anche la rivoluzione culturale.
K– Di Edoarda Masi, oltre ai suoi libri, si conosce
poco, che puoi dire?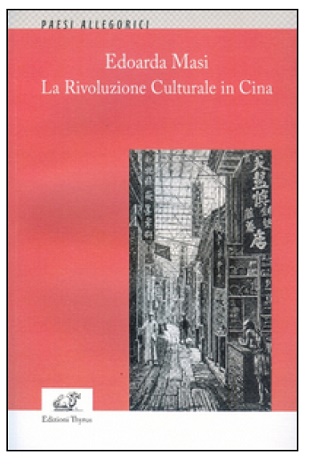
E.M. – Ho avuto una vita in fondo di piccola borghese italiana piuttosto comune, salvo il fatto che sono andata in Asia. Oggi tutti i giovani che studiano il cinese vanno in Asia. Ho studiato a Parma. Quando ho finito il liceo i miei professori mi hanno detto che dovevo studiare fisica, e avevano ragione. Io ero liberissima di scegliere, mio padre era una persona eccezionale, avanti di tre generazioni, anche per il modo di educare alla libertà. Però esisteva un influsso indiretto, mio padre era un uomo di lettere, e mi appariva naturale orientarmi verso le lettere.
K. – Lo dava per scontato?
E.M. – Lo davo io per scontato. Ho finito il liceo nel 1944 durante l’occupazione tedesca, ho anche saltato un anno perché ero stanca di andare a scuola. Sono del 1927 e avevo saltato un anno anche in prima elementare. A Parma non c’era la facoltà di lettere, c’era a Bologna, però a quel tempo non c’erano neanche i treni, c’era la guerra. Allora mi sono iscritta a legge a Parma, sapendo che poi avrebbero consentito il passaggio di facoltà. Dopo la liberazione ho fatto il passaggio a Bologna, ma è durato un mese e mi sono stufata. Voi non avete idea, mica esistevano i treni per andare da Parma a Bologna, mica esistevano le automobili private. Neanche parlarne, forse qualcuna. Dovevi andare con altra gente a dei posti di blocco fuori città, dove gli alleati controllavano il traffico. Lì si aspettava che passassero dei camion e ci si faceva caricare. I camion erano principalmente di due tipi: militari degli alleati, oppure camion di quelli che facevano la borsa nera da sud a nord. Dal momento in cui c’è stata l’unificazione c’era uno squilibrio enorme di prezzi fra il sud inflazionato e il nord, e su questo giocavano i borsari neri. Mi ricordo che una volta tornai da Bologna in cima a un enorme catasta di limoni che veniva dal sud. Comunque era una vita impossibile, non si poteva studiare in quelle condizioni. Allora con un’amica decidemmo di rimanere a legge a Parma. Così mi sono laureata in legge. E non mi dispiace nemmeno perché è stato un allargamento di orizzonti, data l’educazione tutta letteraria ricevuta a casa.
K. – La stessa cosa ha detto Piero Bertolucci dell’Adelphi, che si è laureato in legge, poi per caso un giorno è andato a sentire le lezioni di Colli ed è rimasto folgorato dalla filosofia. Però anche lui è laureato in Legge.
E.M. – Le donne a quel tempo non potevano entrare in magistratura, ma io non ci pensavo nemmeno, neanche l’avvocato volevo fare, non mi piaceva. Ma la laurea in legge dà accesso a quasi tutte le professioni “umanistiche”. Comunque, l’aspetto nuovo per me rispetto al liceo è stato lo studio della storia del diritto pubblico. é un modo di studiare la storia che nel liceo non c’è, la storia delle istituzione non si fa. Un modo di fare la storia d’Italia sconosciuta nel campo dei letterati. E poi si scopre che i migliori testi di letteratura latina sono quelli dei giuristi, sono testi meravigliosi di grande sintesi e di grande razionalità, dove appare il genio propriamente latino.
Vedi, per esempio, la definizione della violenza morale: «Quamvis si liberus essem noluissem tamen coactus volui».
Dopo la laurea in legge, la prima esigenza era lavorare subito, qualunque lavoro. In questo senso la mia generazione è molto diversa da quelli che oggi volentieri resterebbero a casa della madre fino a cinquant’anni, se potessero. è vero che ci sono condizioni di lavoro difficili, che non è facile trovare casa e lavoro, però in queste condizioni la gente si assesta... Io ho avuto la fortuna che la mia adolescenza, tarda adolescenza, i miei diciassette anni, hanno coinciso con la Liberazione. La storia d’Italia è stata in armonia con la mia crescita personale. L’entusiasmo, veramente grande nei primi anni dopo la Liberazione, ha coinciso per me con il momento in cui uno apre gli occhi sul mondo. È un dato generazionale: tutte le mie compagne, donne, figlie della gente per bene di Parma (una categoria non particolarmente brillante per spirito d’indipendenza), tutte volevamo lavorare il più presto possibile. Era un desiderio d’indipendenza, non volevamo dipendere dai genitori. C’era per me anche la considerazione di mio padre, che era un funzionario statale. Gli stipendi, fino agli anni Sessanta, non ti permettevano quasi di vivere, essendo dirigenti statali – quindi poveri. Allora perché dovevo farmi mantenere da mio padre? Lo trovavo anche immorale. Avrei avuto la possibilità di restare all’Università, ma allora era ancora peggio di adesso: avrei dovuto lavorare gratis per anni. E poi, pur andando d’accordo con i genitori e benché non mi abbiano mai ostacolata in nulla, c’era il desiderio di indipendenza, volevo contare sulle mie forze.
K. - Sei figlia unica?
E.M. – No, ho un fratello, un po’ più giovane. Al primo concorso che c’è stato per le biblioteche, ho colto l’occasione. Allora erano concorsi piuttosto difficili. Ho lavorato per un anno alla Nazionale di Firenze. Ci stavo benissimo, ero contenta, c’erano i colleghi giovani con cui ci divertivamo...
K. - Giovanni Semerano era alla Nazionale di Firenze?
E.M. – Lavorava alla Marucelliana. Direttrice della Nazionale era la Mondolfo, allieva e amica di Giorgio Pasquali. Miei colleghi erano Umberto Albini, grecista, entrato col mio stesso concorso, Martini, che ha lavorato in seguito in una biblioteca dell’ONU, Casamassima, poi diventato direttore della Nazionale. Eravamo stati reclutati quasi tutti contemporaneamente, nei primi concorsi del dopoguerra dopo anni di stasi. Ero felice e contenta, ma non potevo sopravvivere, letteralmente, con lo stipendio, anche avendo trovato una pensione di bravissima gente che mi nutriva bene (per lo meno mangiavo e avevo una cameretta). Però pagati quel mangiare e quella cameretta, non potevo comprarmi più nulla, non era possibile.
I miei si erano trasferiti a Roma e c’era una casa grande... A Roma ci sono tante biblioteche, mio padre dirigeva allora l’Angelica, non potevo essere una dipendente di mio padre... Sono andata alla Biblioteca Nazionale, che era nella confusione più completa. Venivo da quella di Firenze che era diretta bene, bene ordinata, e lì mi sono trovata nel caos. Gli anni Cinquanta, gli anni di Roma, sono stati per me anni bui, i più brutti della mia vita. Roma è una città faticosissima per chi non abita in centro e noi abitavamo in periferia. Tu passi la giornata sui mezzi di trasporto. Mi ero fatta un’automobilina, una Topolino usata, ma anche così per arrivare a casa dalla biblioteca impiegavo più di un’ora. Per fortuna facevamo orario continuato, però arrivavo a casa alle tre, mangiavo, e dopo cadevo in letargo. Se dovevo uscire, si trattava di ricominciare, riuscivo ad arrivare in centro alle sei. Questo dei tempi di trasporto è un aspetto importante, può bloccarti la vita.
Roma è una città bellissima, e mi era familiare come i corridoi di casa mia, però è una città ministeriale e l’odioso ambiente burocratico romano aveva delle propaggini anche nelle biblioteche. Mentre le biblioteche fuori Roma in fondo erano dei regni indipendenti. A Roma finivano per essere tutti parenti, amici e imparentati con i funzionari e gli impiegati dei ministeri, c’era una presenza burocratico-ministeriale anche dentro la biblioteca. Poi, sulla Biblioteca Nazionale di quel tempo, diretta in modo strambo, ci sarebbe da scrivere un romanzo gogoliano.
K. - Dalla Biblioteca Nazionale di Roma sei andata all’Istituto di Studi Orientali?
E.M. - No. A Roma ho studiato il cinese per quattro anni, poi, nel 1957, sono andata in Cina chiedendo l’aspettativa. Sono stata un po’ più di un anno all’Università di Pechino. Avevo una borsa di studio di tre anni a Pechino, ma avrei perso il lavoro in Italia, quindi sono tornata. Anche perché, per ciò che mi importava – la lingua contemporanea – ne sapevo abbastanza, e ho continuato a studiare in Italia. Sono tornata nel 1958, sono stata a Roma ancora due o tre anni, ma lì la vita era sempre più insopportabile, e ho chiesto il trasferimento a Milano. Me lo hanno dato immediatamente, in un giorno, d’ufficio, mi hanno pagato il trasporto delle mie cose, perché nessuno statale voleva trasferirsi da Roma a Milano – dove vi era carenza di personale, mentre a Roma ce n’era in eccesso. Sono rimasta a Milano alla Biblioteca Nazionale Braidense fino alla pensione, nel 1973.
K. - Il tuo ruolo era quello di direttore di biblioteca?
E.M. - No, di dirigente. Prima esistevano solo tre categorie: una categoria esecutiva, una intermedia, e la carriera direttiva. Ero nella carriera direttiva. In quegli anni Andreotti promosse una riforma: dopo un certo numero di anni di servizio e un esame, i funzionari direttivi diventavano dirigenti. Fui tra questi. Il dirigente può avere un incarico di direzione ma in una biblioteca grande oltre il direttore c’è un certo numero di dirigenti. Io ero comunista, perciò non ho mai avuto una direzione. Ne ero stata preavvertita, ancora quando ero a Roma, dal capodivisione del personale: “Lei è brava e molto quotata, ma sarebbe meglio che smettesse di occuparsi di questioni sindacali”. Era uno legato con Gonella, il ministro democristiano della Pubblica Istruzione. Gli risposi: “Finché c’è la libertà....” E lui: “Che Dio ce la conservi!” e fu tutto. Non mi importava molto di questa limitazione della carriera, anche perché lo studio della storia e della letteratura della Cina stava diventando il mio interesse principale. Quello dei bibliotecari è un ambiente di persone civili. La direttrice ti rispettava. Nelle biblioteche allora vigeva il matriarcato: i concorsi di accesso erano difficili, si richiedeva una preparazione notevole, ma la professione dava poche soddisfazioni e pochissimi soldi. Così la maggior parte delle candidate a quella carriera era di donne. Questa gestione femminile funzionava bene, tutto sommato. Negli ultimi anni di Brera mi occupavo degli acquisti e del personale, una funzione dirigente anche se formalmente non ero il direttore.
Mentre lavoravo a Brera ho conseguito la libera docenza in letteratura cinese e ho ottenuto all’Orientale di Napoli l’incarico di letteratura cinese per quattro anni. Era una vita pesante, facevo la pendolare da Milano a Napoli. Non guadagnavo niente, mi davano ottantamila lire che non bastavano neanche per pagare il treno o l’aereo. (Fruendo già di uno stipendio statale potevo avere solo un’integrazione.) A Napoli ho insegnato letteratura cinese moderna. L’incaricato era qualcosa di simile all’associato di oggi, però in condizione di precariato, nominato anno per anno. Il pendolarismo naturalmente era pesante: a Napoli facevo cinque ore di lezione di seguito per due giorni. Erano i primi anni Settanta, il clima era post-sessantottesco, si passavano ore a parlare con gli studenti, era molto bello, ma pesante. Quando tornavo a Milano, trovavo accumulato il mio lavoro, non c’era un altro a farlo, nonostante l’autorizzazione ad assentarmi per due giorni. Ero nella “force de l’âge” e ce la facevo, ma con fatica.
Poi avrei dovuto decidermi a dare il concorso per la cattedra; in quel momento lo avrei vinto, i concorrenti erano pochi. Però avrei dovuto trasferirmi a Napoli: una città che amo molto, dove mi sono trovata benissimo. Ancora oggi con gli ex colleghi napoletani sono in ottimi rapporti. Ma la mia vita era impiantata a Milano, che non era quella di oggi, ci stavo molto bene. Qui avevo gli amici e i compagni, qui ero organizzata. Allora dissi: “Che m’importa, mica voglio fare la carriera universitaria”. Più tardi gli amici napoletani me ne hanno rimproverata, per aver perduto il contatto con gli studenti. È un rapporto che ancora oggi, per quanto occasionale, funziona molto bene. Eppure da giovane pensavo di non essere portata all’insegnamento; ma c’era un equivoco, pensavo all’insegnamento nella scuola media, ed effettivamente non sono portata ad avere a che fare coi ragazzini, a tener buona la classe, ecc. L’insegnamento a ragazzi adulti è un’altra cosa.
K. - E i «Quaderni piacentini»?
 E.M. - è la storia di Milano di quegli anni. Perché
volevo restare a Milano? Perché gli anni Sessanta sono stati anni
meravigliosi. Da Roma a Milano c’è stato per me un cambiamento radicale.
È ancora la storia d’Italia. Gli anni Cinquanta sono i Dieci inverni di
Fortini. Per molti di noi sono stati anni bui; poi è venuta la
liberazione degli anni Sessanta. Prima dei «Quaderni piacentini» avevo
conosciuto i compagni dei «Quaderni rossi». Raniero Panzieri l’avevo
conosciuto già a Roma, tramite un amico comune; allora era un dirigente
della sinistra socialista. Quando ero partita per la Cina, mi aveva
detto: «Mandaci delle corrispondenze». Allora dirigeva «Mondo operaio»
che durante la sua direzione fu una rivista bellissima. é durato poco,
però, perché venne emarginato dal suo stesso partito e finì a Torino a
lavorare per Einaudi. Era amico di Franco Fortini. Fortini l’ho
conosciuto, perché al ritorno dalla Cina ho scritto un libro e glielo ho
mandato. Pensavo fosse lo scrittore adatto a capirlo. Il manoscritto gli
piacque molto. Lo presentò, con Panzieri, alla redazione Einaudi di cui
faceva parte. Questo è accaduto pressappoco nello stesso periodo in cui
mi sono trasferita a Milano, all’inizio degli anni Sessanta. Da Einaudi
vi fu un grande litigio intorno al mio libro, perché conteneva delle
critiche al regime cinese, fatte da un punto di vista socialista, non da
un punto di vista ostile. Però alcuni non erano d’accordo, sostenevano
che qualsiasi critica sarebbe andata a vantaggio del nemico. C’era
questa mentalità un po’ stalinista, anche fra non stalinisti. Si oppose
principalmente Renato Solmi, un uomo straordinario col quale in seguito
ho stretto amicizia, ma in quel momento troppo osservante e timoroso
dell’eresia. Allora il libro non uscì. In quell’occasione ho avuto un
rapporto un po’ più discorsivo con Panzieri il quale mi consigliò: «Non
lo dare ad altri editori perché perderebbe il suo carattere». Oggi non è
più così, ma allora Einaudi aveva una certa sua nobiltà. Le case
editrici non erano tutte uguali come oggi. Così l’ho messo nel cassetto.
Soltanto qualche anno fa è uscito da Feltrinelli con il titolo Ritorno a
Pechino, con un’introduzione esplicativa.
E.M. - è la storia di Milano di quegli anni. Perché
volevo restare a Milano? Perché gli anni Sessanta sono stati anni
meravigliosi. Da Roma a Milano c’è stato per me un cambiamento radicale.
È ancora la storia d’Italia. Gli anni Cinquanta sono i Dieci inverni di
Fortini. Per molti di noi sono stati anni bui; poi è venuta la
liberazione degli anni Sessanta. Prima dei «Quaderni piacentini» avevo
conosciuto i compagni dei «Quaderni rossi». Raniero Panzieri l’avevo
conosciuto già a Roma, tramite un amico comune; allora era un dirigente
della sinistra socialista. Quando ero partita per la Cina, mi aveva
detto: «Mandaci delle corrispondenze». Allora dirigeva «Mondo operaio»
che durante la sua direzione fu una rivista bellissima. é durato poco,
però, perché venne emarginato dal suo stesso partito e finì a Torino a
lavorare per Einaudi. Era amico di Franco Fortini. Fortini l’ho
conosciuto, perché al ritorno dalla Cina ho scritto un libro e glielo ho
mandato. Pensavo fosse lo scrittore adatto a capirlo. Il manoscritto gli
piacque molto. Lo presentò, con Panzieri, alla redazione Einaudi di cui
faceva parte. Questo è accaduto pressappoco nello stesso periodo in cui
mi sono trasferita a Milano, all’inizio degli anni Sessanta. Da Einaudi
vi fu un grande litigio intorno al mio libro, perché conteneva delle
critiche al regime cinese, fatte da un punto di vista socialista, non da
un punto di vista ostile. Però alcuni non erano d’accordo, sostenevano
che qualsiasi critica sarebbe andata a vantaggio del nemico. C’era
questa mentalità un po’ stalinista, anche fra non stalinisti. Si oppose
principalmente Renato Solmi, un uomo straordinario col quale in seguito
ho stretto amicizia, ma in quel momento troppo osservante e timoroso
dell’eresia. Allora il libro non uscì. In quell’occasione ho avuto un
rapporto un po’ più discorsivo con Panzieri il quale mi consigliò: «Non
lo dare ad altri editori perché perderebbe il suo carattere». Oggi non è
più così, ma allora Einaudi aveva una certa sua nobiltà. Le case
editrici non erano tutte uguali come oggi. Così l’ho messo nel cassetto.
Soltanto qualche anno fa è uscito da Feltrinelli con il titolo Ritorno a
Pechino, con un’introduzione esplicativa.
Panzieri mi disse: «Comincia a frequentare le riunioni dei nostri “Quaderni rossi”» e mi fece fare dei lavori. La rivista era quasi un sottoprodotto di un intenso lavoro precedente. Non ci si incontrava come si incontra una redazione, ma per organizzare un lavoro di studio, di inchiesta e di ricerca – specialmente nelle fabbriche torinesi. Si facevano grandissime sedute di discussioni. Poi alcuni dei risultati venivano pubblicati nella rivista, di cui uscirono appena cinque numeri. È stata per me un’esperienza straordinaria, ho avuto modo di incontrare un insieme di cervelli eccezionale. C’erano Vittorio Rieser, Giovanni Mottura, Liliana e Dario Lanzardo, Michele Salvati che era l’ala destra, Bianca Beccalli, Mariuccia Salvati, Mario Tronti, Toni Negri, Adriano Sofri, ecc... Il nucleo di quella che è stata poi la sinistra italiana pensante, in ogni direzione, è passato dalla rivista. Dopo un certo periodo, entrai a far parte della redazione.
I «Quaderni piacentini» erano più collegati con Fortini, che lavorò per metterli in rapporto con i «Quaderni rossi». Non è vero che Fortini fosse un isolato, come dice Rossana Rossanda. Al contrario, era un organizzatore di cultura, metteva in relazione le persone, in un continuo lavorio. (Un numero sull’America Latina fu realizzato insieme dalle due redazioni.) Grazie a Fortini cominciai a frequentare i «Quaderni piacentini», conobbi Piergiorgio Bellocchio, Grazia Cherchi, Goffredo Fofi. In seguito entrai nella redazione.
K. - Il valore di queste persone era davvero elevato, molte delle cose allora dette si sono rivelate azzeccate.
E.M. – Intorno ai «Quaderni rossi» gravitavano anche un gruppo toscano, amici di Sofri, i veneziani incluso Luigi Nono, anche dei napoletani e dei siciliani. Poi c’era anche Giovanni Pirelli, che fra l’altro ha aiutato finanziariamente la rivista. Un uomo straordinario. Molti degli articoli dei «Quaderni piacentini» sono stati tradotti in Europa e anche altrove. In Francia, la rivista di Sartre riprendeva i nostri articoli. In Germania, facevano opuscoletti dei nostri articoli. è stato un momento in cui è esistita in Europa una sinistra seria, nella quale gli italiani hanno avuto un ruolo. «Quaderni piacentini» per un certo periodo è stata la più bella rivista europea di politica-cultura.
K. - Come mai, al di là del dato della naturale dispersione (c’è chi muore ecc.), questo patrimonio si è smarrito?
E.M. - Si è persa la funzione sociale dell’intellettuale. Quei cervelli in qualche modo erano ancora un residuo di certa cultura umanistica, e si sono dispersi. Il mio amico Giuseppe Gozzini diceva: «Il Sessantotto è stato il rantolo finale di un periodo che durava da più di un secolo». Se si guarda la storia delle persone, ognuno è rimasto un atomo per conto suo, una monade. Chi aveva una sua moralità personale, come Bellocchio o Vittorio Rieser, si è mantenuto isolato, facendo il proprio lavoro in modo decente, ma isolato. Quelli che davano meno importanza alla salvaguardia della loro purezza intellettuale, sono entrati nel giro o economico o politico o accademico - qualche volta diventando uomini di regime.
K. - Ma non è per l’incapacità di pensarsi in un modo diverso?
E.M. - No, come diceva Marx, non si può fare come il Barone di Münchausen che cercava di sollevarsi da terra tirandosi per i capelli. Tu non puoi più avere quella funzione nella società, se la società non te la dà. Sei autoreferenziale. Lo sei perché ti hanno messo in quella condizione.
K. - Ma non è anche per il fatto che gli intellettuali non si sono pensati fuori da questa autoreferenzialità?
E.M. - Secondo me, individualmente questo è accaduto. Alcuni non lo hanno fatto. Ma se parliamo della categoria, la categoria è determinata anche dal contesto. L’individuo molto meno, si può salvare, si chiude nel suo guscio, ha la sua moralità personale, continua a fare le sue cose... Però se pensiamo a una funzione di gruppo, no. Ritengo che nella fase attuale dell’evoluzione economica e politica mondiale, quelli che erano chiamati gli intellettuali, ma che in realtà erano gli intellettuali umanisti, anche del tempo di Marx e poi via via, non hanno più quella funzione che hanno avuto per un secolo e mezzo: in quanto oggi le leve del potere, sia pure con asservimento, sono semmai nel campo della scienza e della tecnologia. Per esempio, il sistema di dominio attraverso la biogenetica, senza una scienza asservita sarebbe impossibile. Il potere delle transnazionali della chimica senza il potere degli universitari sarebbe impossibile. Questi sono veramente gli asserviti pericolosi. Quando tu hai un asservito in campo umanistico, il peggio che può fare è del giornalismo fetente... non dico che faccia poco male, ma tutto sommato... Il potere in questo senso è limitato, mentre non lo è il potere di quelli che organizzano l’industria chimica in un certo modo e sono asserviti a quella, oppure la corporazione dei medici, quelli che insomma hanno finito per fare della vita umana qualcosa di spaventoso. Diceva un mio amico, ora morto: «Se mi ammalo gravemente, la prima cosa che faccio è nascondermi»; perché uno non vuole diventare oggetto di esperimenti, campare tre anni di più, sottoposto a sofferenze atroci per quei tre anni in più che lo fanno vivere.
Certamente è necessario un contributo di pensiero teorico al cambiamento effettivo, di filosofia, di economia ecc... sarà necessario questo, ma non c’è ancora. Chi detiene il potere non ha più bisogno di intellettuali, si serve di altri, di mezze calzette.
K. - Ma come possiamo considerare questi degli intellettuali? Non hanno la coscienza critica dei propri statuti scientifici o umanistici. E perché questa scissione fra scienziati e intellettuali umanistici? Si tratta di intellettuali e basta.
E.M. - Sono d’accordo, dico solo che detengono un pezzo di potere, e per di più sono asserviti.
NOTE
[1] Edoarda Masi è nata a Roma nel 1927. Si è laureata in giurisprudenza a Parma nel luglio1948. Dal 1950 aI 1973 è stata bibliotecaria (ruolo direttivo, ruolo dirigente) nelle biblioteche statali (Biblioteca Nazionale di Firenze, Biblioteca Nazionale dì Roma, Biblioteca Nazionale di Milano). Nel 1956 si è diplomata presso l’ISMEO di Roma in lingua e istituzioni cinesi e in lingua russa. Dopo un corso di perfezionamento in lingua cinese presso lo stesso ISMEO, ha frequentato un corso speciale di lingua cinese presso l’Università di Pechino, nel cui campus ha vissuto nel 1957 e 1958. Dal l968 al 1971 ha tenuto seminari sulla cultura e la storia della Cina moderna presso le università di Torino, Venezia, Roma, l’Istituto superiore di sociologia di Milano, l’Istituto universitario orientale di Napoli, l’istituto di studi storici e sociologici dell’Università di Urbino, l’istituto superiore di scienze sociali di Trento. Nel 1970-71 ha insegnato lingua cinese presso l’ISMEO di Milano. Nel l971 ha conseguito la libera docenza in lingua e letteratura cinese. Negli anni accademici 1971-72, 1972-73,1973-74 è stata incaricata dell’insegnamento di letteratura cinese moderna e contemporanea presso l’istituto universitario orientale di Napoli.. Nel 1976 ha lavorato informalmente presso l’Ambasciata d’Italia a Pechino. Nell’anno accademico 1976-77 ha insegnato lingua italiana presso l’Istituto universitario di lingue straniere di Shanghai. Oltre che in Cina, ha viaggiato (in Asia) in Giappone e in Vietnam. Ha collaborato a diversi periodici, fra i quali: «Alfabeta», «Annali Feltrinelli», «Antigone», «Asahi», «Aut aut», «Azimuth», «Cina», «Critica, revista de la Maestria en ciencias sociales de la Universidad Autonoma de Guerrero», «Guerre & Pace», «Ideologies», «Kursbuch», «L’Indice», «Linea d’ombra», «Nuova rivista storica», «L’ospite ingrato: Annuario del Centro studi Franco Fortini», «Quaderni dell’amicizia (Associazione Italia-Cina», «Quaderni piacentini», «Quaderni rossi», «Rivista di storia contemporanea», «Rivista storica del socialismo», («Socialist revolution», «Tempi moderni», «Les temps modernes», «Ulisse». Ha pubblicato i seguenti volumi: La contestazione cinese. Torino, Einaudi, 1968;1969;1971 (trad. tedesca: Die chinesische Herausforderung. Berlin, Wagenbach, 1970); Lo stato di tutto il popolo e la democrazia repressiva. Milano, Feltrinelli, 1976; Per la Cina. Milano, Mondadori, 1978 (trad. americana, con variazioni e aggiunte: China Winter. New York, Dutton, 1982); Breve storia della Cina contemporanea. Bari-Roma, Laterza, 1979; Il libro da nascondere. Casale Monferrato, Marietti, 1985;Cento trame di capolavori della letteratura cinese. Milano, Rizzoli, 1991 ;Ritorno a Pechino. Milano, Feltrinelli, 1993; Storie del bosco letterario. Milano, Scheiwiller, 2002. Ha curato le seguenti traduzioni dal cinese:
Cao Xueqin, Il sogno della camera rossa. Torino, UTET, 1964; 1981; Lu Xün, La falsa libertà. Torino, Einaudi, 1968; Feng Youlan, Sommario di storia della filosofia cinese, in: “i problemi della pedagogia”, 1971-72; Lao She, Città di gatti. Milano, Garzanti, 1986; Confucio,I dialoghi. Milano, Rizzoli, 1989; Chuanqi: storie fantastiche Tang. Parma, Pratiche, 1994; Lu Xün, Erbe selvatiche. Macerata, Quodlibet, 2003.
[2] Kamen’ Rivista di poesia e filosofia, anno XIII – n° 23 – gennaio 2004 – Direttore Responsabile: Amedeo Anelli